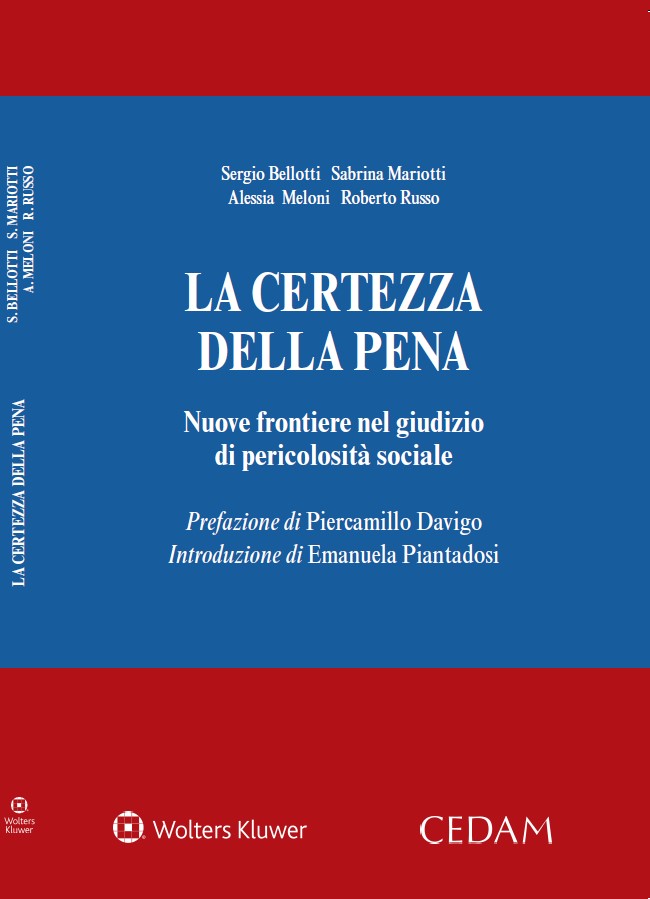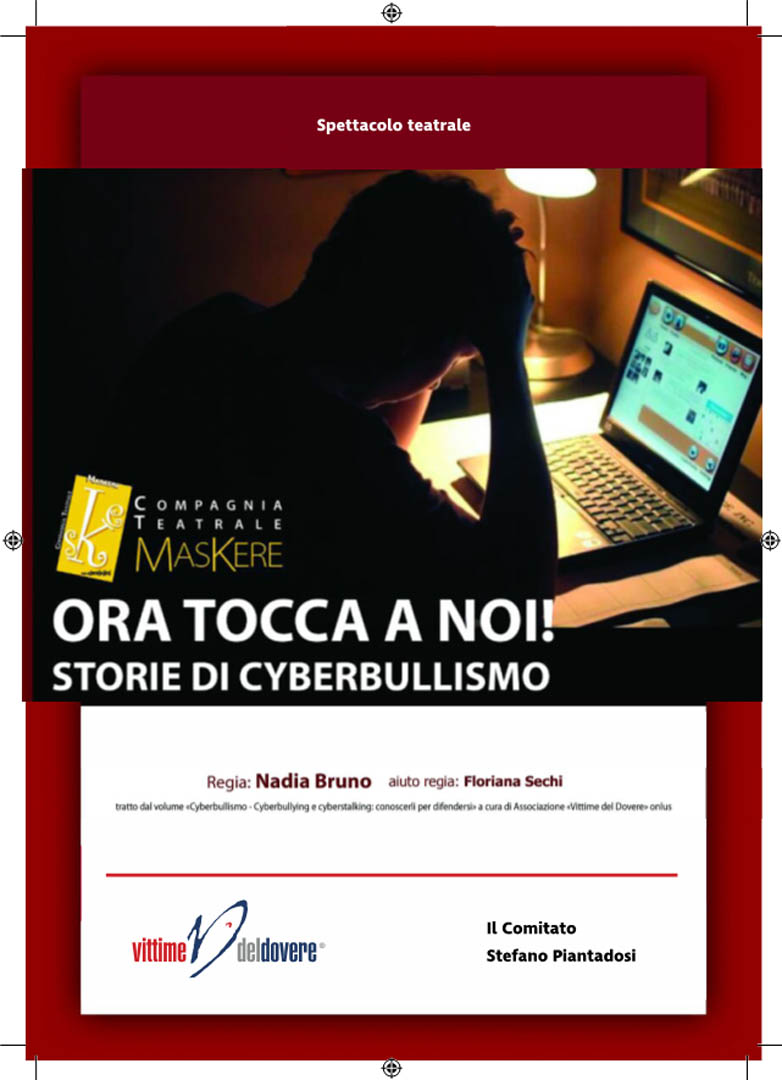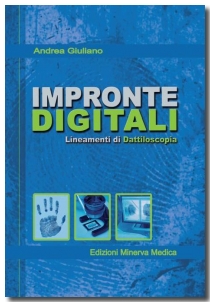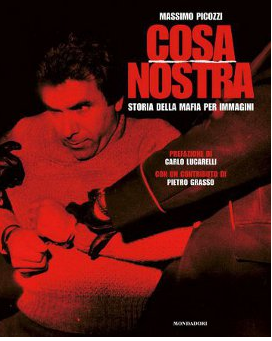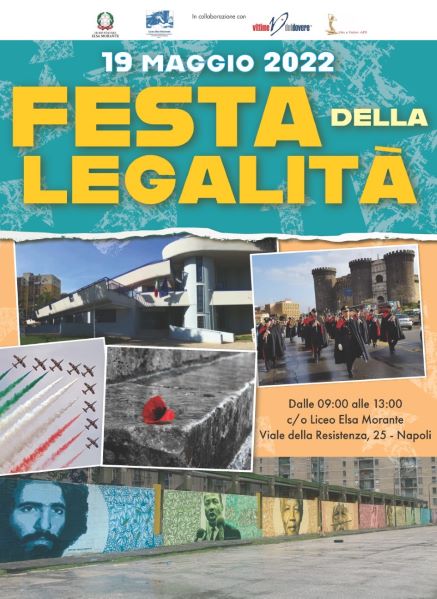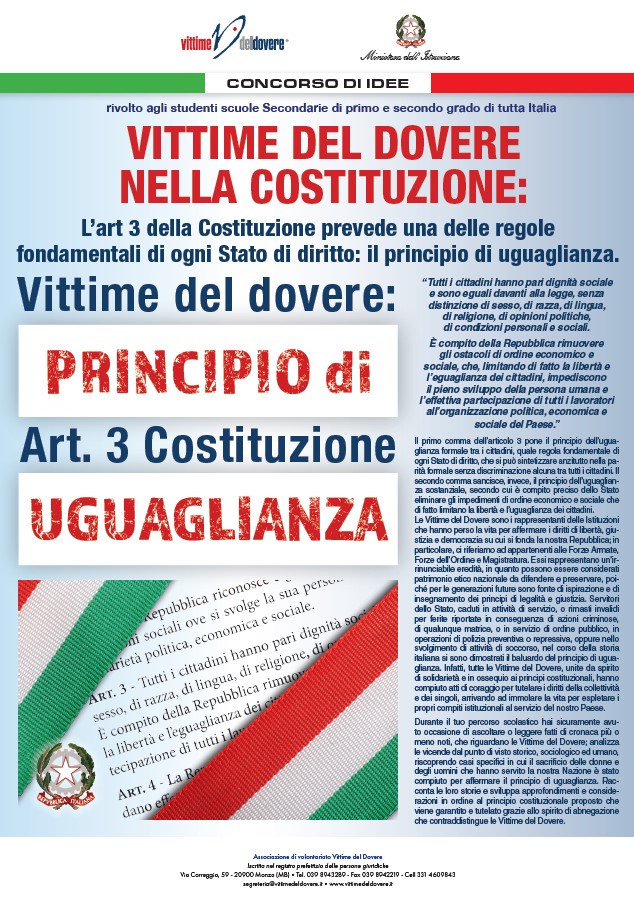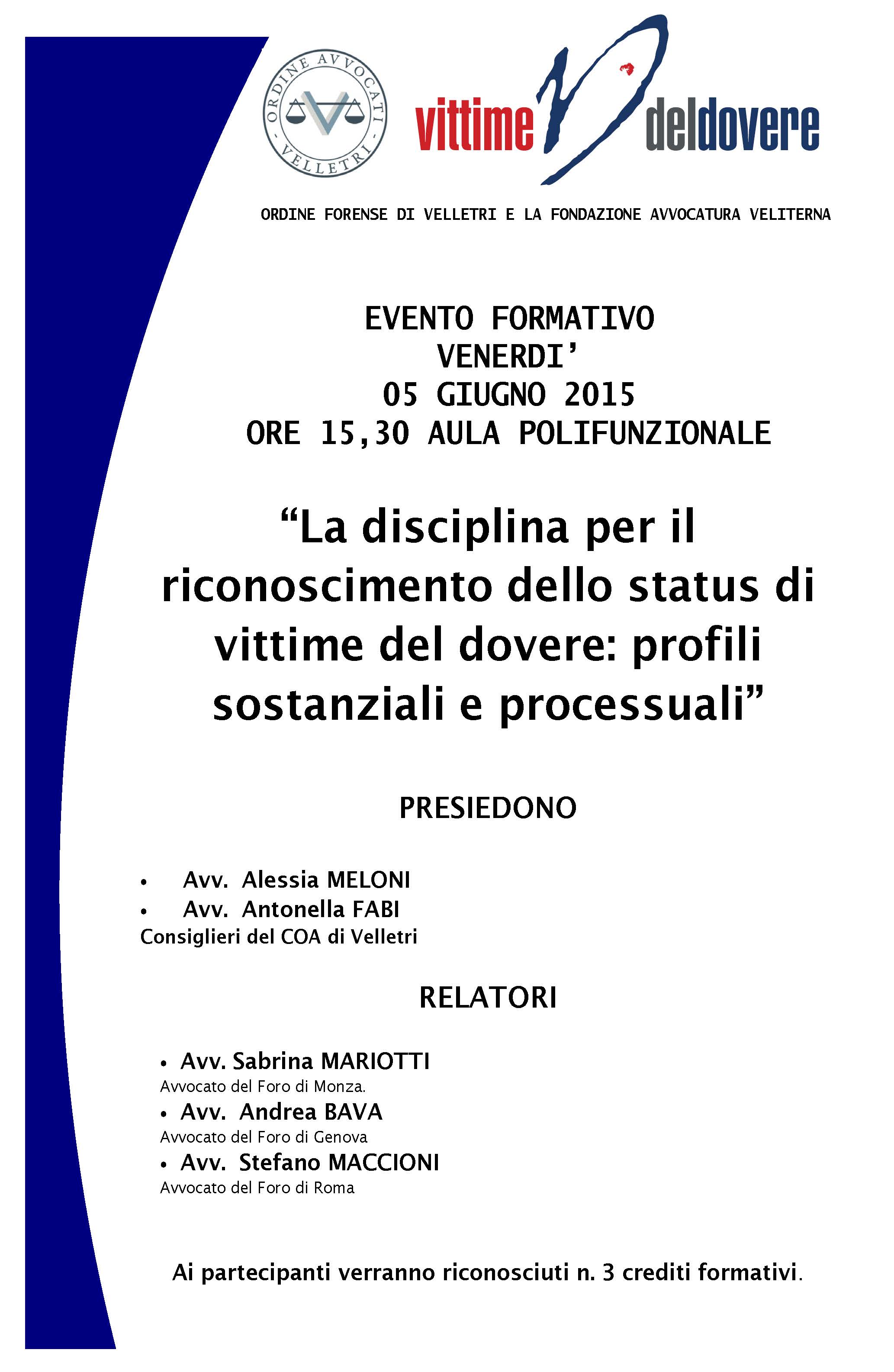Vittime del Dovere ETS-ODV
C.F.94605940157
via Correggio 59
20900 Monza (MB)
Tel. 039 8943289
Fax 039 8942219
Cell 331 4609843
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it
Vittime del Dovere La storia I traguardi raggiunti Organizzazione Attestati Il nostro logo Diventa un associato Consulenza legale Centro di sostegno Elenco Soci Onorari Bilanci I calendari Domande frequenti (FAQ)
educazione alla legalità 10° Anniversario Libri e pubblicazioni Lotta alle mafie Monumento Vittime del Dovere Cronologia delle attività
Vittime Legislazione Atti parlamentari Entrate derivanti
da Enti Pubblici Convenzioni
e protocolli
con Enti pubblici Convenzioni
e protocolli
con Enti privati Donazioni Campagna sociale Privacy policy Numeri & link Dona il 5 x mille Resoconto 5 x mille

Locate Triulzi, periferia sud di Milano. Capannoni industriali, auto e camion che sfrecciano in tutte le direzioni. Da 38 anni una croce di ferro cerca di imporre un’oasi di silenzio al boato del traffico, ricordando che qui, nel 1980, venne ucciso il maresciallo dei carabinieri Stefano Piantadosi. Il 15 giugno di quell’anno, a poca distanza, era in corso una gara ciclistica. Tra il pubblico, Piantadosi aveva notato un uomo dall’aria sospetta e, dopo averlo fermato, lo stava portando in auto in caserma per un controllo. Prima che un collega più giovane riuscisse a perquisirlo, l’uomo estraeva la pistola e sparava nella nuca a Piantadosi. Si sarebbe scoperto dopo che, l’assassino era un ergastolano evaso, condannato a 30 anni di carcere.
“Era il 15 giugno 1980. Avevo 14 anni – racconta Emanuela, la figlia di Piantadosi – l’ho saputo dal parroco, perché mia madre era devastata dal dolore. All’inizio ci dissero che papà era ferito e per qualche ora abbiamo sperato di rivederlo vivo”. Per onorare la memoria di suo padre, Emanuela ha fondato nel 2007 l’associazione “Vittime del dovere”, una rete di solidarietà che oggi collega 500 storie di servitori dello Stato caduti o feriti in servizio.
Nella sede dell’associazione, un bene confiscato alla criminalità organizzata incontro l’ingegner Paolo Salsone. Nel 1986, a Brancaleone, quando aveva 11 anni, fu ferito alla testa dalla raffica che uccise suo padre Filippo, condannato a morte dalla cosche quando comandava la polizia penitenziaria di Reggio Calabria. “Stavo rientrando a casa con mio padre, mia madre e mio fratello quando udii delle esplosioni. Alla prima pensai che si trattasse di una bombola di gas, ma venni subito colpito alla testa da due pallettoni e da un terzo a una spalla. Mio padre, morì poco dopo all’ospedale di Locri”.
Pare che la ragione dell’omicidio, sia stata il fatto che Filippo Salsone aveva denunciato il controllo che la ‘ndrangheta aveva imposto sul carcere di Reggio Calabria, che i boss usavano come un albergo. “Ho saputo che era morto solo venti giorni dopo – racconta Salsone – la mamma me lo disse quando ero ormai fuori pericolo. A volte lo rivedo in sogno, ma il risveglio è sempre molto duro, perché quando mi sveglio non lo vedo accanto a me”.
Gli chiedo che ricordo abbia di suo padre: “Mio padre era una persona normale – risponde – ma sapeva da che parte stare”.
E’ un sopravvissuto anche l’ex-colonnello e ora generale della riserva dei carabinieri Paolo Rota Gelpi. “Il proiettile mi era entrato nella clavicola – racconta – era il colpo di una 38 special sparato da due metri. Ruppe la clavicola, risalì lungo il collo e si fermò vicino alla colonna vertebrale”. Il 16 maggio del 1988, vicino a Padova, tre rapinatori legati alla mafia del Brenta, inseguiti dai carabinieri dopo aver svaligiato una banca, si erano nascosti in un tunnel della ferrovia. Paolo Rota Gelpi, entrò per primo nel tunnel e venne ferito da uno dei banditi che morì subito dopo nel corso della sparatoria con gli altri carabinieri.
“Battista Tombolato, il bandito che mi sparò, aveva tatuata sulla coscia una pistola – dice Rota Gelpi – nel codice della mala vuol dire che era destinato a morire in una sparatoria”.
Fatta da volontari, l’Associazione si batte perché le famiglie dei caduti o dei feriti siano tutelate anche da un punto di vista economico. “La perdita di un congiunto, oltre al trauma, causa alle famiglie anche una serie di problemi economici – spiega Emanuela – ora la legge, nel corso degli anni ha creato varie tipologie di vittime e noi ci siamo battuti perché venga annullata la differenza fra vittime del terrorismo della criminalità organizzata o di quella comune. Chi indossa la divisa non può essere discriminato in base alla pallottola dell’assassino”.
Nei giorni scorsi Forza Italia è insorta contro Di Battista. Alessandro Sallusti, definendolo “cretino assoluto”, gli ha ricordato i successi imprenditoriali di Berlusconi: “Le famiglie a cui ha dato un lavoro, agli artisti che si sono esibiti nelle sue tv, i tifosi del Milan, gli italiani che lo hanno votato”. Fatti indiscutibili, come è un fatto la sentenza Dell’Utri, citata dal Nino di Matteo, secondo cui: “È stato stipulato un patto con Cosa nostra, intermediato da Marcello dell’Utri, che è stato mantenuto dal 1974 fino al 1992 dall’allora imprenditore Silvio Berlusconi”.
La domanda che ne scaturisce – e che non udrete in nessun talk show – è questa: un premier, un ministro, un leader politico, come fa a chiedere a poliziotti, carabinieri, magistrati, di rischiare la pelle ogni giorno, contro le cosche se si porta addosso una sentenza come questa?
Sostieni l'associazione!
Fai una donazione con
IT33A0760101600000087577888
-
sabato 28 febbraio
-
sabato 28 febbraio
-
domenica 01 marzo
-
domenica 01 marzo
-
domenica 01 marzo
-
lunedì 02 marzo
-
lunedì 02 marzo
-
lunedì 02 marzo
-
lunedì 02 marzo
-
lunedì 02 marzo
-
martedì 03 marzo
-
martedì 03 marzo